Spazio per tutti, sulla Terra e oltre
SRI NEWSLETTER – 10 maggio 2023
Bernard Foing & Adriano V. Autino
Space Renaissance International ha recentemente lanciato una campagna mondiale per aggiungere un 18° SDG all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. La nostra iniziativa è risultata essere in sintonia con iniziative simili, intraprese da altre organizzazioni di advocacy spaziale, ad esempio la National Space Society degli Stati Uniti, e molte altre. Tutte queste organizzazioni promotrici stanno ora lavorando a una campagna congiunta. Primi appuntamenti saranno la presentazione, da parte dell’NSS, dello #Space18SDG al COPUOS (il Comitato delle Nazioni Unite per l’Uso Pacifico dello Spazio extra-atmosferico) la prima settimana di giugno, e un panel organizzato da SRI all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, per il 18 settembre.
“Spazio per tutti, sulla Terra e oltre, uno sviluppo spaziale a trazione civile, con comunità umane che vivono e lavorano nello spazio per espandere e moltiplicare i benefici per tutti i popoli della Terra.
Quanto sopra è il concetto principale che sostiene la nostra proposta, cercando di rendere evidente, in poche parole, che, sebbene apprezziamo e consideriamo molto importante l’enorme contributo finora dato dalle tecnologie spaziali al raggiungimento dei 17 SDG terrestri, pensiamo che non basteranno a superare la crisi globale dello sviluppo umano sul nostro pianeta madre, qualora l’umanità rimanesse chiusa e confinata entro i suoi limiti.
Sappiamo che non sarà facile ottenere che un 18° obiettivo incentrato sullo spazio sia aggiunto all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Fin dai suoi primi passi, la nostra iniziativa ha sollevato critiche e obiezioni. Tuttavia riteniamo che la nostra iniziativa sia molto opportuna e tempestiva, mentre le Nazioni Unite stanno andando a una revisione degli SDG, probabilmente entro il 2025, una sorta di riesame di medio termine, sulla road-map del 2030. Inoltre, l’iniziativa #Space18SDG offrirà al movimento spaziale un’occasione perfetta per spiegare un semplice concetto ancora nascosto e mistificato nell’opinione pubblica: che 8 miliardi di terrestri non possono più farcela su un solo pianeta, e che abbiamo quindi abbiamo un urgente bisogno di iniziare ad espanderci, spostando il nostro sviluppo all’esterno. La New Space Economy sta guadagnando slancio e ogni anno supera e contraddice le previsioni fatte dagli esperti: la dimensione di $ 1 trilione sarà probabilmente raggiunta non nel 2040, ma già prima del 2030.
La New Space Economy si conferma il settore più dinamico, guidando di fatto la crescita dell’economia globale, dando la possibilità agli SDGs 7, 8 e 9 (energia, sviluppo industriale e lavoro) di fare il loro lavoro essenziale, sostenendo tutti gli SDGs sociali (zero povertà, zero fame, ecc…). Tutti gli SDG sociali npon possono fare a meno della crescita. Anche gli SDG ambientali hanno bisogno di crescita energetica e tecnologica, per poter essere implementati. Eppure la crescita industriale ed economica, se chiusa all’interno dei confini della Terra, entra drammaticamente in conflitto con gli SDG ambientali. La società del web, infatti, ha bisogno di più energia, non di meno. Anche la mobilità elettrica incrementerà la domanda di energia elettrica. La società elettronica, in termini generali, ha bisogno di alcuni materiali, che possono essere estratti in poche località sul pianeta Terra: le guerre per le risorse hanno solo cambiato argomento, dal petrolio alle terre rare.
Uno sviluppo spaziale a guida civile risolverà, in prospettiva, sia i problemi di cui sopra, sia molti altri. In primo luogo, sulla Luna e su molti asteroidi si possono trovare abbondanti risorse, tra cui terre rare e molti altri materiali preziosi, ponendo fine alla carenza di materie prime per la produzione di componenti elettronici. Ciò contribuirà alla pace sulla Terra, all’aumento dei posti di lavoro e al riavvio della crescita economica. In secondo luogo, spostando progressivamente le industrie nello spazio geo-lunare, l’ambiente del pianeta Terra sarà progressivamente sollevato dal fardello dello sviluppo industriale, permettendo alla madre Terra di prendere fiato e possibilmente riprendersi dalla crisi climatica e dall’inquinamento. In terzo luogo, lo spostamento delle industrie all’esterno dimezzerà la domanda di energia sulla superficie terrestre, poiché le industrie si alimenteranno nello spazio, direttamente dal Sole, e la domanda di energia sulla Terra sarà solo quella dei privati cittadini. Ultimo, ma non meno importante, l’espansione della civiltà nello spazio riaccenderà la creatività in tutti i popoli del pianeta Terra. Le giovani generazioni hanno sofferto troppo, negli ultimi anni, a causa delle pandemie del Covid19, ed ora per l’ insorgere di guerre e scontri violenti. I sistemi educativi sono stati compromessi ovunque. Sebbene siano state sviluppate nuove tecniche di apprendimento a distanza, molti studenti hanno perso interesse e l’abbandono scolastico ha subito un’impennata, così i problemi psicologici, ed un sentimento generale di paura e sfiducia nel futuro.
Il lancio di grandi progetti, costruendo sulla Luna, nei punti Lagrange e oltre, riaccenderà la speranza e l’entusiasmo delle giovani generazioni, motivando nuove ondate di ingegneri, filosofi umanisti, scienziati, tecnici.
I nostri figli domani saranno astronauti? Quella era l’era dell’Apollo, quando i bambini guardavano Buzz Aldrin camminare sulla Luna e sognavano di essere astronauti… Nella stragrande maggioranza i bambini di oggi saranno cittadini e lavoratori spaziali. I cittadini spaziali avranno bisogno che i diritti civili siano estesi allo spazio. Anche i lavoratori spaziali rivendicheranno i loro diritti. Vivendo e lavorando nello spazio, saremo protetti dalle radiazioni cosmiche? Avremo la gravità simulata, per evitare il decadimento delle nostre ossa e muscoli? Avremo ambienti verdi negli habitat spaziali?
Il 18° SDG richiede tutto quanto sopra, e di dare quindi maggior priorità alla relativa ricerca scientifica. E ancora, proponiamo anche che la storia dello spazio e della ricerca scientifica siano aggiunte a tutti i programmi educativi, dalle Elementari all’Università. Bisogna cominciare ad insegnare la storia dell’amore, non solo quella delle aggressioni, delle colonizzazioni, degli imperi e delle guerre. I nostri figli devono imparare la storia delle persone che hanno dedicato la loro vita all’umanità, per il progresso della civiltà. Il 18° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile porterà anche questo grande valore educativo.
Questa campagna “Space4all on Earth and Beyond” sviluppa il piano d’azione che abbiamo concordato al Congresso SRI del 2021, promuovendo la scienza spaziale, la tecnologia, l’economia e l’occupazione, la collaborazione internazionale, la pace, le risorse, l’ispirazione, la formazione e di fatto un rinascimento spaziale.
Bernard Foing, SRI, Presidente
Adriano V. Autino, SRI, Fondatore ed ex Presidente
12 giugno 2023: segui il livestream sul canale Youtube Space Renaissance: https://youtube.com/live/A5CAyaNl7GI?feature=share
Fai clic su “going” all’evento di Facebook: https://www.facebook.com/events/768080504967832/.
Firma la petizione #Space18SDG: https://www.change.org/space18sdg
Aggiungi la tua organizzazione al gruppo dei promotori: https://spacerenaissance.space/sign-the-18th-sdg/
Per favore, non dimenticare di sostenere Space Renaissance:
Unisciti alla SRI Crew: https://spacerenaissance.space/membership/international-membership-registration/
Fai una donazione: https://spacerenaissance.space/donate-to-space-renaissance/
Guarda e iscriviti al canale YouTube di Space Renaissance: https://www.youtube.com/@spacerenaissance
Scarica anche una versione pdf di questa newsletter.


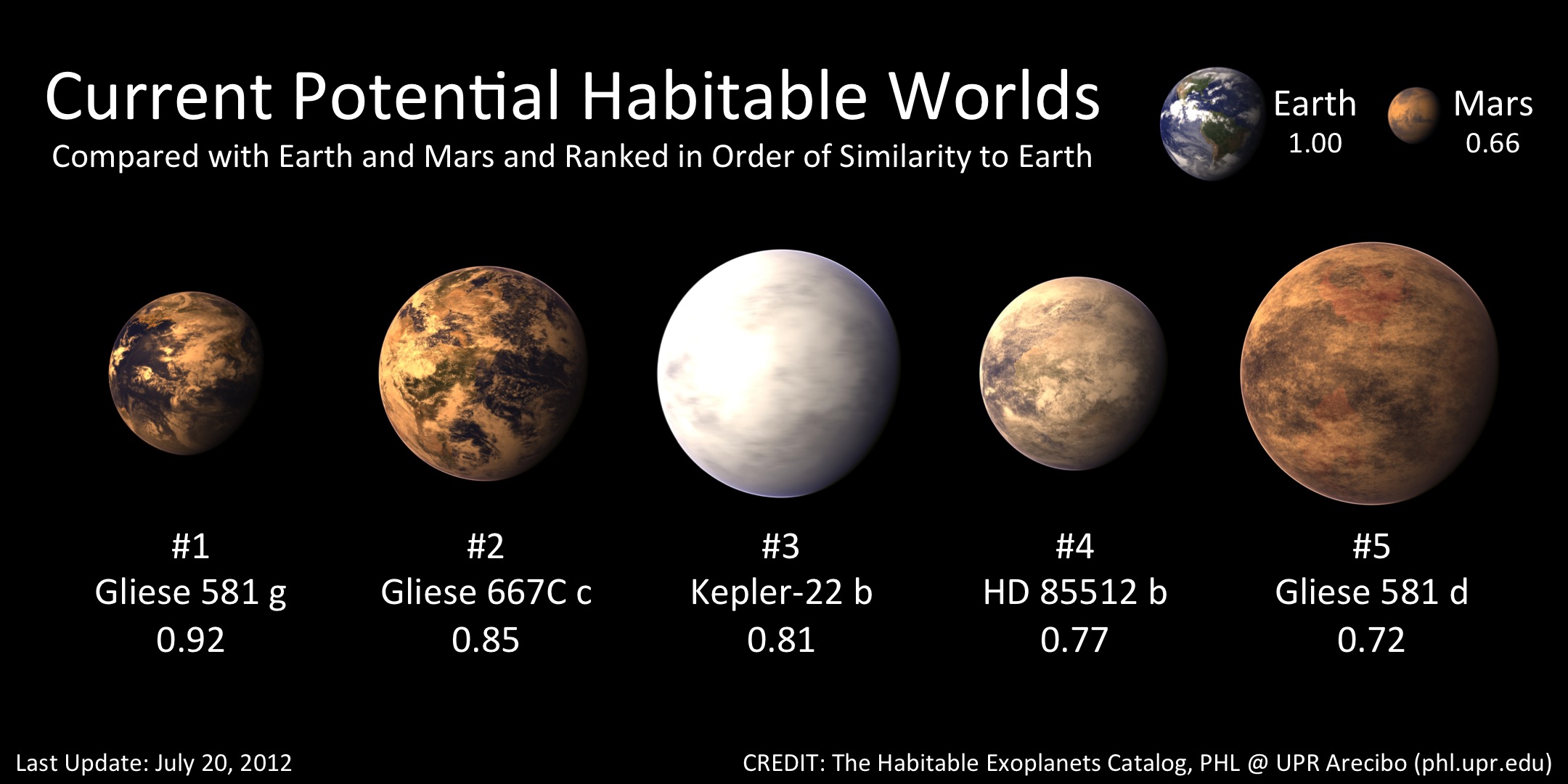
 Nell’ambito degli incontri tematici promossi da Space Renaissance International, incontriamo la Dott.ssa Luigina Ferretti, già direttrice dell’IRA-INAF e tuttora elemento di punta del medesimo Istituto.
Nell’ambito degli incontri tematici promossi da Space Renaissance International, incontriamo la Dott.ssa Luigina Ferretti, già direttrice dell’IRA-INAF e tuttora elemento di punta del medesimo Istituto.

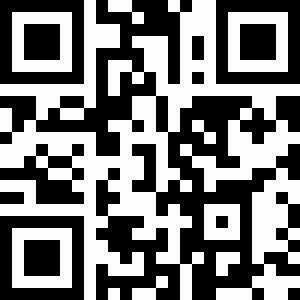




 Space Renaissance France
Space Renaissance France  Space Renaissance USA, Inc.
Space Renaissance USA, Inc.  Space Renaissance Academy
Space Renaissance Academy Space Renaissance Initiative Group
Space Renaissance Initiative Group