Innanzitutto voglio dare il bentornato ad AstroPaolo (Paolo Nespoli), appena tornato dalla sua missione sulla Space Station, e ringraziarlo di cuore, per aver volato lassù anche per tutti noi, che per il momento siamo ancora costretti a terra!
Lo Space Shuttle e la Sojuz sono due sistemi progettati per portare astronauti addestrati in orbita bassa. Dei due il più moderno, lo Space Shuttle, è ormai stato rottamato, da anni, mentre la Sojuz, praticamente la stessa macchina che portò in orbita Yuri Gagarin, invece vola ancora. Per quanto rigaurda la Sojuz, gli esperti sostengono che la sua longevità si deve alla strategia industriale della Sojuz, prodotta in sia pure piccolissima serie, mentre dello shuttle vennero costruiti cinque pezzi unici. Qualsiasi macchina, dopo trent’anni di utilizzo, deve essere ritirata. Il tremendo failure rate dello shuttle — due fallimenti totali su cinque, con perdita dell’intero equipaggio — conferma questa triste verità. AstroPaolo ha volato su entrambi i sistemi, e non nasconde che il viaggio sulla Sojuz e’ molto più duro e scomodo, rispetto al viaggio sullo Shuttle.
Ci sarebbero da fare diverse considerazioni, circa la visione strategica di chi ha permesso questo sostanziale arretramento tecnologico, che costringe oggi a reinventare completamente le tecnologie per accedere all’orbita ed andare oltre. E tutto questo ancora in un’ottica di mera esplorazione, e pervicacemente non espansionistica. Sono ormai molti a criticare la politica della NASA degli ultimi 50 anni. La storia sarebbe stata molto diversa, se si fosse realizzato lo Space Shuttle secondo i disegni orginali di Krafft Ehricke (ancora visibili sugli archivi NASA). Tale progetto proseguiva dall’esperienza dell’X15, un sistema a due stadi, entrambi completamente riutilizzabili. L’X15 era un aereo suborbitale militare, che fece 200 voli a quota 100 km (suborbitale), nel 1969. L’X15 veniva portato a quota 30 km da un bombardiere B52, poi veniva sganciato e raggiungeva quota 100 km grazie al proprio motore a razzo. Invece fu realizzato lo space shuttle, una macchina non completamente riutilizzabile, le cui missioni costavano 500 milioni ciascuna, in cinque pezzi unici. Ne beneficiarono soprattutto i costruttori di razzi spendibili, che hanno potuto dominare il mercato, mantenendo molto elevato il costo all’orbita, fino ad un paio d’anni fa, quando Space X ha iniziato a far volare i suoi razzi interamente riutilizzabili. Il prezzo elevato, intorno ai 20.000 $/kg, aveva inoltre tenuto lontane dalle frontiera la gran parte delle aziende private della frontiera ai provati, cosa che non poteva dispiacere alle lobby militari, determinate a mantenere il controllo assoluto sullo spazio.

Per quanto lo Space Shuttle fosse più comodo, rispetto alla Sojuz, certo rimaneva un veicolo destinato unicamente al trasporto di astronauti addestrati, e non di passeggeri civili. Per quanto riguarda la ISS, essa rimane una stazione sperimentale, i cui requisiti principali riguardamo in gran parte la sperimentazione degli effetti della microgravità sulla fisiologia umana. E non la sperimentazione di un ambiente sicuro e confortevole, magari dotato di gravità artificiale, che permetta la residenza di lungo periodo. Che bisogno ci sarebbe, infatti, di sperimentare così tanto gli effetti della microgravità, se si cominciassero a sviluppare stazioni orbitali dotate di gravità artificiale? Magari la priorità si potrebbe spostare sulla sperimentazione di tecniche di protezione dalle radiazioni cosmiche. Ad oggi, gli astronauti sono ancora considerati cavie da esperimento, e non pionieri di un programma di colonizzazione spaziale. Si direbbe quasi che si voglia dimostrare come lo spazio non possa mai diventare un nuovo ambiente per lo sviluppo civile, perché le sue condizioni sono troppo ostiche…
La distanza tra volo astronautico e volo spaziale civile, posto che esista la volontà politica di colmarla, rimane cospicua. Basta pensare alle grandi accelerazioni e decelerazioni che il decollo verticale ed il rientro in atmosfera comportano, le vibrazioni del lancio, le condizioni di sicurezza, che nessuna compagnia di assicurazione si sentirebbe oggi di assicurare.
Sia la Sojuz che lo Shuttle rientrano in atmosfera come un sasso, durante la fase calda di circa 25 minuti, e l’elevato calore che si sviluppa — più di 1000 gradi — rappresenta un rischio notevole per gli astronauti a bordo delle capsule. In Italia il CIRA studia da molti anni delle tecniche di rientro più morbide, con un angolo d’attacco più basso, e la possibilità di navigare durante la fase calda, diminuendo così l’attrito ed il conseguente calore, nonché materiali più resistenti al calore, rispetto a quelli utilizzati a suo tempo dallo space shuttle.
La microgravità, anche se non protratta più di sei mesi, produce danni fisiologici, oltre a richiedere un periodo di riabilitazione dopo il rientro a terra. Il periodo di grande gioia che prova un astronauta in orbita è seguito da lunghi e tristi mesi di lotta per riconquistare la mobilità e la posizione eretta, qui sul fondo del pozzo gravitazionale.
Il viaggio spaziale è, per il momento, concepito in termini di missioni esplorative di andata e ritorno, e non per attività industriali o residenziali di lungo periodo.
Fra l’altro, negli ultimi tempi, più o meno dal viaggio della nostra AstroSamanta Cristoforetti — alla quale, come ad AstroPaolo, va tutto la nostra gratitudine per i rischi affrontati e per la grande capacità di divulgazione –, le difficoltà e le durezze del volo astronautico non vengono più taciute al pubblico, e perlomeno la gente può rendersi conto di quanto siamo ancora lontani dallo spazio, come società civile…
Se si vuole andare nella direzione dell’espansione civile si dovranno inquadrare altre priorità di ricerca, orientate alla creazione di condizioni civili di sopravvivenza e di mantenimento della salute nello spazio. Sistemi di trasporto a decollo orizzontale, con accelerazioni più morbide, rientro in atmosfera più prolungato, protezione dalle radiazioni cosmiche, strutture rotanti (magari semplicemente due habitat connessi da un cavo), capaci di generare 1 g di gravità artificiale. Quanto siamo ancora lontani da questa prospettiva? Vi sono ormai forze — la nuova imprenditoria detta new space — che abbattono i vecchi monopoli e spingono verso l’apertura della frontiera. Ma sappiamo che l’effettiva apertura della frontiera alta potrà solo essere il risultato di una collaborazione tra la ricerca (le Agenzie, detentrici del know how) e le aziende private, capaci di abbattere i costi.
Il secondo congresso nazionale di Space Renaissance Italia si terrà presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna il 18 e 19 Maggio 2018.
Intendiamo indicare chiaramente lo spazio, e l’inizio effettivo di attività civili industriali in orbita terrestre e in area cislunare, come linee guida per lo sviluppo economico del nostro Pease. Vi sono diversi fattori che concorrono alla realizzazione di quanto sopra: sviluppo di sistemi di trasporto passeggeri civili a basso costo, manovrabilità interorbitale, capacità di estrarre carburanti, ossigeno ed acqua da risorse lunari ed asteroidee, protezione dalle radiazioni cosmiche, gravità artificiale, sperimentazione di ecosistemi artificiali, che permettano la vita umana confortevole e sicura su infrastrutture abitative spaziali. Tutto questo si rende necessario ed urgente, se si comincia a pensare in termini di residenza e lavoro nello spazio, e non più solo di missioni di esplorazione di durata relativamente breve.
L’Italia, con la sua grande tradizione umanista di attenzione alla persona, puo’ giocare un ruolo primario nella rapida validazione di tecnologie abitanti l’espansione civile, e nella soluzione dei problemi essenziali alla sopravvivenza umana nello spazio. E’ ormai tempo che lo spazio entri a pieno titolo nelle politiche di sviluppo del nostro Paese.
Venite a discuterne con noi al congresso, il 18 e 19 maggio 2018!





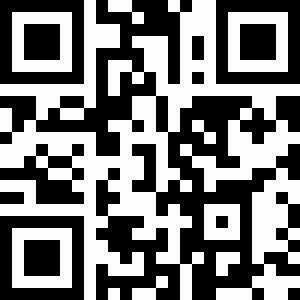



 Space Renaissance France
Space Renaissance France  Space Renaissance USA, Inc.
Space Renaissance USA, Inc.  Space Renaissance Academy
Space Renaissance Academy Space Renaissance Initiative Group
Space Renaissance Initiative Group