di Adriano V. Autino
Quello dell’intelligenza artificiale è un argomento di portata talmente ampia che non ci si può limitare a considerazioni legate ai ritorni di investimento, effetti sull’occupazione, o altri aspetti meramente economici. Il tema investe la dimensione filosofica a più lungo termine, prova ne sia che due grandi protagonisti della scena industriale contemporanea, come Mark Zuckerberg ed Elon Musk, proprio su questo terreno si sono recentemente confrontati.
Iniziando con le considerazioni più generali, l’Intelligenza Artificiale (IA) fa parte degli sviluppi tecnico-scientifici cosiddetti GRAIN (Genetics, Robotics, Artificial Intelligence, and Nanotechnology), tutti molto promettenti, ma che, come ho già scritto più volte in passato, ed anche nel mio ultimo libro “Un mondo più grande è possibile!”, di cui riporto qui un passo, hanno tutti un grave handicap. “L’economia terrestre è ormai fallita, le Industrie terrestri non possono più crescere né svilupparsi oltre. L’ulteriore sviluppo della scienza terrestre nel mondo chiuso potrà fare miracoli, come sempre, ma il loro effetto sarà di breve durata, conferendo alla civiltà forse pochi anni di apparente ripresa dalla crisi. La caduta successiva sarà peggio, se il mondo dovesse restare chiuso. In mancanza di spazio lo stesso sviluppo tecnologico potrà imboccare strade involutive, tendenti a deprimere l’iniziativa, la creatività e lo spirito di avventura che da sempre caratterizza la nostra specie. Infatti, in un contesto di fabbisogni energetici mortificati dalla scarsità di risorse, il sistema non potrà che tendere alla staticità, all’immobilismo fisico e quindi culturale, all’equilibrio, forse, ma l’equilibrio della vecchiaia e della morte. Da tempo le forze che fiancheggiano la prematura estinzione della nostra civiltà tentano di “educarci” ad una maggiore stanzialità, a limitare i viaggi. Lo stesso termine “navigazione in rete” appare particolarmente odioso, in questa prospettiva, addirittura patetico, in quanto suggerisce di abbandonare le velleità dell’esplorazione, in favore di una comoda poltrona davanti allo schermo televisivo, dove possiamo fruire di suoni ed immagini di terre lontane, o addirittura di altri pianeti… Suoni ed immagini ripresi da professionisti dell’esplorazione, meglio se mediante ausilii completamente robotici. Tutta la “cultura” (se così la vogliamo chiamare) del Ventunesimo Secolo ci suggerisce che ogni cosa è meglio lasciarla fare ai professionisti, e diventare sempre più dei consumatori, tenuti in poltrona, all’ingrasso, fisico e mentale. Salvo che poi il giochetto non funziona, perché l’economia ne risulta terribilmente depressa, i mercati diminuiscono, e tutto rischia di finire molto più velocemente di quanto gli strateghi del cosiddetto “soft landing” avessero previsto, tramutandosi presto in “hard landing”. Si dimostra così una volta di più che la pretesa di aver compreso a fondo i meccanismi dell’economia, ed ancor più, l’illusione di poter agire su tali processi come se si avesse a che fare con un sistema totalmente deterministico e controllabile, sia una delle tante false metafisiche, con le quali la nostra civiltà si fa del male, e questa volta rischia di causare un crash irrecuperabile.” Da queste poche righe si comprende già quale sia il mio pensiero, a proposito dello sviluppo delle IA, alle quali non sono affatto contrario, in linea di principio, purchè siano al servizio degli umani, e non in senso lato. Vale a dire che i civili possano usufruirne così come oggi utilizzano i personal computer, i tablet ed i telefoni portatili. Usufruirne come degli strumenti, avendone cioè il completo controllo, ed avendo la piena libertà di attivarne o disattivarne ogni singola funzione. Quindi, tanto per capirci, auspico un controllo molto maggiore di quello che abbiamo oggi su telefoni e computer, dove è sempre meno l’utente a decidere quali applicazioni installare, quale grado di autonomia devono avere, e quanto il sistema deve essere aperto ad interventi esterni.
Questo significa, anche, un approccio alla tecnologia ben diverso da quello oggi spacciato da google, whatsapp e facebook, rudimentali IA che già esistono. Niente di strano, a tal proposito, che Zuckerberg si pronunci a favore di non preoccuparsi troppo, dello sviluppo delle IA! Si tratta di mezzi di comunicazione che prendono molte decisioni al posto dell’utente, se così lo vogliamo ancora chiamare, e spesso ne scopriamo i risultati in seguito a cose spiacevoli, di cui avremmo volentieri fatto a meno. Le modalità di privacy, ad esempio, hanno impostazioni di default molto aperte, ed è solo spendendo ore in ricerche che riusciamo a capire (i) quali regole esistono (ii) su quali possiamo influire (iii) come ci conviene settare il sistema. Tutto questo ha avuto origine quando l’informatica di consumo (Microsoft) ha sconfitto e rottamato l’informatica industriale (Digital Equipment), in virtù dei numeri economici enormemente superiori. Così i personal computer, i telefoni smart ed i social media, sono dati in mano ad “utenti” incompetenti dal punto di vista informatico, che non si vogliono “annoiare” troppo chiedendo loro di impostare i parametri del sistema. Gli si vuole dare un mezzo che possano usare subito e divertirsi, per default connesso ed aperto. Perché questo è lo scopo: che la gente si diverta e, divertendosi, compri. Hey, ma guarda, si fanno del male! Cosa vuoi che sia, intanto comprano, e questo è l’essenziale. Quei quattro fissati che amano mettere sempre i puntini sulle i hanno comunque i mezzi, se hanno conoscenze sufficienti per trovarli, per proteggere la propria privacy ed il proprio libero arbitrio (fino ad un certo punto). Viene da pensare se questo problema del libero arbitrio non si sia già posto, in un passato magari molto remoto, con una qualche super-IA deificata. Se le scritture hanno posto un’enfasi così accentuata sul libero arbitrio… che la nostra stessa idea di Dio (onnipotente, onnisciente, che tutto vede) non sia derivata da un simile passato…

Ma, bando alle divagazioni fantasiose futuriste e passatiste, per adesso non siamo al punto di aver creato o ri-creato un Dio (immagino cosa ne trarrebbe Alessandro Bergonzoni dal concetto della ri-creazione di Dio! ah ah!), o un Comitato Centrale artificiale (fate un po’ voi), anche se indubbiamente molti sognano qualcosa del genere… Ad oggi qualsiasi intelligenza artificiale, a meno che vi siano sviluppi di cui non sono a conoscenza, consta di un motore inferenziale (l’algoritmo), e di un database di regole, definito da un esperto. Ad esempio, se voglio una IA che controlli i pozzi di petrolio ascoltando il rumore che fa la trivella, dovrò chiedere ad un vecchio esperto di pozzi di trasferire il suo know how dentro un database di regole. Essenziali sono dunque i database delle regole, quindi è molto importante da chi sono scritte tali regole, e per quali scopi. Da umanista, credo si dovrebbe partire dalle tre leggi della robotica, definite da Isaac Asimov nei primi anni quaranta del secolo scorso: (1) Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. Vorrei subito aggiungerne alcune altre: (4) qualsiasi IA dovrà essere utilizzabile come strumento personale da un singolo utente, o da gruppi di utenti che ne decidano la condivisione totale o parziale (5) qualsiasi IA dovrà risiedere fisicamente su un supporto hardware in piena disponibilità fisica dell’utente, e non su un’infrastruttura centralizzata (6) qualsiasi IA deve potersi connettere in rete solamente a discrezione dell’utente, e per gli scopi definiti dall’utente (7) qualsiasi IA potrà installare applicazioni sull’infrastruttura informatica dell’utente solo su esplicito consenso di quest’ultimo (8) qualsiasi IA sarà completamente inattiva finchè non sia stata parametrizzata dall’utente secondo le funzioni e le modalità desiderate da quest’ultimo (9) qualsiasi IA sarà completamente inattiva finchè l’utente non l’abbia attivata, e sarè disattivabile (standby) in qualsiasi momento (10) il grado di autonomia di qualsiasi IA per quanto riguarda le ricerche e qualsiasi tipo di iniziativa in rete sarà definibile dall’utente, da 0% a 100% (11) in nessun caso qualsiasi IA potrà iscrivere automaticamente l’utente a servizi di alcun genere, anche se gratuiti, senza aver prima avvisato l’utente e richiestone il permesso. Sono certo che queste poche regole elementari sono solo l’inizio, e che ne seguiranno altre, in base a riflessioni più approfondite ed ampie casistiche (use case).
È chiaro che si fa presto a sconfinare nel territorio dell’etica. E questa è indubbiamente la questione più importante, quando si parla di IA. Tecnicamente un database di regole può essere scritto sia da Batman che dal Joker… i database di regole delle IA dovranno quindi essere certificati da apposite authority, e gli utenti dovrebbero acquisire una sorta di patente di guida, prima di iniziare ad usare una IA. Pensiamo che usare una IA sia meno complesso e meno pericoloso, rispetto alla guida di un’automobile, o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, di terra, mare o cielo? Ad IA di diversi livelli di pericolosità dovrebbero corrispondere diversi livelli di patente, così come avviene per i mezzi di trasporto. Non si può pensare che la preparazione per l’utilizzo di un’IA di navigazione e ricerca in rete sia la stessa che servirà per utilizzare un robot per operazioni minerarie asteroidee. E che dire di una IA in grado di fornire pareri legali, a supporto della magistratura, oppure di una IA capace di operare chirurgicamente? Non si pensi, del resto, che l’utilizzo di un robot per lavori domestici presenti minori complessità o necessità di attenzione. Dai pochi esempi che ho fatto s’intuisce anche come si stia parlando di applicazioni molto diverse tra di loro. Abbiamo già assistito, nella storia del software, a diverse fasi: inzialmente esisteva il mestiere del programmatore, che scriveva software. Poi l’elettronica avanzata (automazione) è entrata ovunque, negli elettrodomestici, nei telefoni, nelle auto, nella produzione industriale, … Oggi il mestiere del programmatore non esiste più, essendo il software stato inglobato nelle diverse branche dell’ingegneria. Chi progetta il software da inserire in elettrodomestici o in un telefonino, o il software di automazione di una centrale elettrica, non si definisce più programmatore, bensì un progettista nel comparto industriale in cui presta la sua opera. Un processo simile si può prevedere anche per le intelligenze artificiali. Dopo un periodo, (speriamo breve, perché già non se ne può più J) di discussioni feroci tra entusiasti e detrattori, sociologhi e tuttologhi, le IA saranno quietamente assorbite nei diversi sistemi, che diventeranno così dei sistemi “intelligenti”. Questa grande varietà di utilizzo delle IA, tra l’altro, darà origine a tutta una serie di nuovi mestieri, a cominciare dai docenti di “scuola guida delle IA”, che dovranno avere una preparazione ben diversa e superiore, rispetto ai tradizionali istruttori di scuola guida, senza nulla togliere, ovviamente, alla professionalità richiesta a quest’ultima categoria.
È chiaro che non è possibile discutere tutta la vastissima materia dell’Intelligenza Artificiale in un solo articolo, che già sta sfiorando pericolosamente la dimensione del saggio, e che potrebbe tranquillamente strabordare nel formato di un piccolo (?) libro… Tuttavia non si può evitare di almeno sfiorare l’argomento dell’occupazione e dei posti di lavoro. Coloro che paventano addirittura la progressiva obsolescenza del genere umano come conseguenza dello sviluppo delle intelligenze artificiali, si possono definire luddisti? Coloro che considerano invece le IA come uno stadio evolutivo dell’intelligenza, che soppianterà a buon diritto l’homo sapiens, sono antiumanisti? È chiaro che nessuna di queste definizioni regge, nel contesto attuale. Di sicuro l’intelligenza artificiale è uno dei vettori del rinascimento che sta lottando per emergere dal maelstrom della crisi globale. Dove ci porterà tutto questo? Per poter muovere un passo alla volta, ma nella direzione giusta, non sarebbe male avere un’idea di dove vogliamo, o possiamo, andare. La mia personale senzasione è che, siccome l’elettronica prosegue nel suo processo di miniaturizzazione, approderà prima o poi su un hardware parzialmente o completamente biologico. La biologia umana, d’altro canto, è già abbastanza inoltrata sulla strada della bionica. Non è difficile prevedere un’epoca in cui le nostre protesi informatiche (strumenti di comunicazione, di calcolo e di archiviazione dati) potranno integrarsi biologicamente con i nostri sottosistemi biologici naturali. Arriveremo così ad una sorta di evoluzione autodiretta, fusione trascendente tra natura e cultura tecnologica. Non credo né ancor meno spero in un futuro dove tutti se ne stanno sdraiati in ozio e le macchine fanno tutto il lavoro. Finiremmo come polli, immobilizzati, imboccati e puliti in cubicoli dotati di tutti i comfort… Situazione che forse potrà sembrare interessante a qualcuna delle tipologie caratteriali umane, ma credo che ai più non possa che fare orrore.
Già, ma a cosa serve, ed a cosa dovrà servire il lavoro? Nella nostra storia come specie culturale, per dare una motivazione completa al lavoro si deve utilizzare la gerarchia dei valori definita da Abraham Maslov, colui che considero il miglior analista delle categorie dei bisogni umani, di gran lunga superiore a Karl Marx, soprattutto perché Maslov discute i bisogni umani, mentre Marx, ed ancor più i suoi epigoni, avevano finito per occuparsi soltanto dei bisogni delle classi subalterne. Dunque il lavoro, nella storia, è servito a mantenere in vita noi umani, assicurandoci protezione dagli eventi naturali, vitto, alloggio, vestiti, mezzi di trasporto, e tutto ciò che serve per soddisfare i nostri bisogni, dai più elementari (anche analizzati da Marx e da diversi marxisti) ai più elevati, categorizzati, appunto, da Maslov. Ci avviamo ad un’epoca in cui potremo dedicarci al 100% a soddisfare i nostri bisogni più elevati, essendo tutti i bisogni più elementari soddisfatti dalle macchine? Oppure le macchine finiranno per scipparci anche quei lavori di alto profilo che ci permettono di soddisfare i nostri bisogni più elevati? È chiaro, in questo secondo scenario, che si tratterebbe di macchine dotate di creatività ed emozione, e del piacere sublime che ne deriva… degli umani artificiali… o degli umani biologici, ma potenziati con hardware bioinformatico aggiuntivo. Alla fine la distinzione potrebbe essere molto sottile: in ogni caso si tratterebbe di esseri evolutivamente superiori all’homo sapiens, quello che hanno in mente i transumanisti , più o meno. Ragionando per ora sul primo scenario, quello che lascia all’homo sapiens le funzioni intellettualmente ed emotivamente superiori, forse sarebbe possibile, a patto che i modelli sociali possano adattarsi a questa nuova situazione. Un modello secondo me molto semplicistico, è quello del reddito universale (Elon Musk), reddito di cittadinanza (M5S), o reddito di inclusione (PD), tutte varianti di un sistema di retribuzione basato sul paradigma esisto-quindi-vengo-pagato. Tale sistema ha un grave difetto: istituirebbe una differenza sociale fondamentale tra chi ha un lavoro (necessariamente di alto profilo intellettuale) e chi vive di quello che, comunque lo si voglia chiamare, sarebbe un sussidio di disoccupazione. Gli occupati avrebbero uno stipendio che permette loro di soddisfare i bisogni più elevati, alla soddisfazione dei quali già contribuirebbe sostanzialmente lo stesso lavoro svolto. Tutti gli altri — una maggioranza drammaticamente grande — avrebbero un reddito che permette soltanto la soddisfazione dei bisogni più elementari (forse). Società utopica? Ne dubito fortemente.
Credo invece si debba pensare ad un modello sociale in cui il grande patrimonio umano venga utilizzato interamente, ed al meglio. Un modello del tipo penso-quindi-vengo-retribuito, in cui la grande maggioranza viene pagata per pensare, per risolvere problemi, per impegnarsi nell’arte, nella progettazione, nello sviluppo della cultura e di mezzi sempre più avanzati per condividerla e per fruirla. Siamo una specie culturale. Il nostro futuro è produrre cultura, possibilità per tutti di viaggiare, di esplorare, di sperimentare direttamente emozioni non accessibili attraverso la tv o qualsiasi mezzo multimediale, di incontrare fisicamente i propri simili, in contesti meravigliosi e romantici, di godere della musica e delle altre arti dal vivo, di produrre musica ed arte live… Tutto questo, ed altro ancora, che noi terrestri terricoli non riusciamo ancora neppure ad immaginare, otto miliardi di persone possono svilupparlo solo espandendosi nello spazio esterno, dove ci sono risorse per lo sviluppo di trilioni di persone.
Ed eccoci ad una questione fondamentale: a chi serve l’espansione nello spazio? Intanto stiamo parlando di una quantità enorme di LAVORO, qualcosa che sembra scarseggiare, oppure adesso parliamo d’altro, quindi ce ne dimentichiamo? Intanto serve all’AMBIENTE, per coloro che si preoccupano prioritariamente di questo aspetto: spostare il nostro sviluppo civile (cioè industriale) fuori dal pianeta allevierà il nostro pianeta dall’ingombro ambientale che il nostro sviluppo rappresenta. L’espansione nello spazio serve alla civiltà. E di quale espansione la civiltà ha un disperato bisogno? L’espansione nello spazio serve alla gente, è la gente, sono i civili terrestri che devono poter viaggiare, lavorare ed insediarsi nel mondo più grande, su città orbitali, asteroidi urbanizzati, stabilimenti industriali lunari, ed oltre. Perché? Guardate una qualsiasi discussione a questo proposito sui social: troverete i pareri più diversi e contrapposti. C’è chi sostiene che siamo “progettati” per vivere sulla Terra, e non sopravviveremmo altrove. C’è chi è convinto che sopravviveremmo benissimo, adattandoci, come ci siamo adattati a vivere in case di ghiaccio nelle regioni polari e nelle capanne di frasche all’equatore. Magari in un futuro non troppo lontano l’homo-sapiens+ auspicato dai transumanisti potrebbe adattarsi biologicamente anche alla bassa gravità ed alle radiazioni cosmiche…
Il guaio è che ciascuno pretende di affermare il proprio punto di vista e le proprie “soluzioni” a discapito delle soluzioni auspicate da altri. Esistono diversi tipi di esseri umani, e tutti hanno diritto a vedere realizzati i loro bisogni più alti (secondo la scala di Maslov), perché tutti questi tipi corrispondono ad impulsi evolutivi, estremamente utili alla civiltà: la mortificazione anche di uno solo di questi impulsi risulterebbe fatale, in un’epoca in cui tutti i nodi verranno al pettine, portando ad una catastrofica implosione della civiltà, oppure ad uno sviluppo sbilanciato, destinato a fallire sul medio o lungo termine. Steven Wolfe, nel suo bellissimo romanzo-saggio “The Obligation”, cataloga sei “endowments” (dotazioni) che caratterizzano altrettanti tipi umani. Il “wanderer” (il vagabondo, o esploratore), che non sopporta di restare a lungo nello stesso posto, ed ha bisogno di muoversi, esplorare, cercare nuovi orizzonti e nuovi panorami, nuove situazioni in cui poter sviluppare la civiltà. Il “settler”, ossia il pianificatore urbano, colui che ama sviluppare infrastrutture adatte alla vita ed alle attività civili. L’inventore, che sviluppa nuove tecnologie per nuovi bisogni. Il costruttore, che realizza quanto progettato dall’inventore. Il visionario, capace di immaginare scenari futuri, ed ispirare gli inventori. Il protettore, che pensa alla sicurezza della gente. In una recente conversazione il dr. Paul Ziolo (docente di psico-storia all’università di Liverpool) ha menzionato il modello Gardner, secondo il quale esistono molti altri tipi di intelligenza, oltre il logico-matematico attualmente considerato come fattore primario e dominante. Le intelligenze di Gardner sono ritmico-musicali, visive-spaziali, verbali-linguistiche, logico-matematiche, corpo-cinestetiche, interpersonali, intrapersonali e naturalistiche. Ha anche ipotizzato l’esistenza di un’intelligenza morale ed esistenziale, che sarebbe fondamentale nel contesto del futuro sviluppo culturale: l’intelligenza morale non può che essere umana, ed avrà un ruolo essenziale ed insostituibile nell’era delle intelligenze artificiali.
Non è difficile identificare, nelle nostre società, tutte queste diverse tipologie caratteriali. E si può quindi riflettere su quanto sia grande il patrimonio umano, nella sua attuale consistenza di quasi otto miliardi di persone. Non è difficile neppure constatare come la stragrande maggioranza di questi tipi abbiano bisogno di spazio, di movimento, di libertà, di godere del contatto anche fisico con altre persone, ed anche della solitudine, quando sentono di doversi concentrare da soli, per creare, elaborare, progettare… Il settimo tipo, identificato da Wolfe, è quello dell’evolutore cosciente, colui che sente dentro di sé l’impulso a guidare l’evoluzione, completando la doppia obbligazione che abbiamo, verso la nostra specie/civiltà, garantendole spazio e risorse per continuare lo sviluppo, e verso il nostro pianeta madre, liberandolo, adesso che abbiamo le tecnologie necessarie, dall’ingombro del nostro sviluppo, trasformandolo in un grande giardino e parco naturale.
Ultimo, per oggi, argomento di discussione: si potrebbe colonizzare lo spazio esterno utilizzando esclusivamente robot ed intelligenze artificiali? Sarebbe questo lo sviluppo, il rinascimento spaziale di cui abbiamo bisogno? Le mie risposte sono due decisi NO. La presenza di colonizzatori umani è indispensabile, benchè coadiuvati da sistemi robotizzati ed IA. Se pure si riesce ormai a teleoperare chirurgicamente, comandando sistemi robotici a distanza, si tratta comunque di distanze terrestri, sulle quali non c’è alcun ritardo. Tra la Terra e la Luna si apprezza già un ritardo di 3 secondi nelle telecomunicazioni, più che sufficiente ad impedire qualsiasi controllo in tempo reale di operazioni delicate. Tra la Terra e Marte 20 minuti. E comunque, le situazioni in cui ci si può venire a trovare sono così varie e largamente imprevedibili, che non sono immaginabili campagne di insediamento ed operatività industriale su vasta scala condotte da IA. La risposta alla seconda domanda non può che essere altrettanto negativa. Non possiamo infatti pensare allo spazio solo come un deposito di risorse da portare a terra, per utilizzarle qui, o comunque per contribuire a mercati unicamente terrestri. Ci sarà vero sviluppo solo se i mercati, e le industrie, e la vita civile, si espanderanno ben oltre i confini dell’atmosfera terrestre. Non posso immaginare un mondo che continua a crescere solo sulla superficie terrestre… un’armata crescente di automi in orbita sulla nostra testa sarebbe una condizione di ulteriore aumento della pressione e dello stress, e di limitazione della libertà di movimento e della fantasia creativa! Ora, se mi legge qualche carattere stanziale, che troverebbe piacevole una tale situazione, per favore non cerchi di imporre la sua visione a noi esploratori/colonizzatori: la nostra visione espansionista non toglie nulla a loro, mentre una loro insistenza nel mantenere il mondo chiuso a noi ed a molti altri toglierebbe l’aria necessaria per vivere e per pensare… e questo non farebbe che aumentare l’entropia psicologica generale, quella che chiamo riscaldamento metafisico globale, che abbiamo invece tutto l’interesse a mitigare!
Questo articolo è pubblicato anche su L’Avanti! online (http://www.avantionline.it/ci-servira-una-patente-per-guidare-le-intelligenze-artificiali/)
L’ultimo libro di Adriano Autino: “Un mondo più grande è possibile! L’espansione della civiltà nello spazio è la questione morale della nostra epoca.”
Ebook:
– su Amazon
– su Mondadori Store
Paperback:
– su Amazon





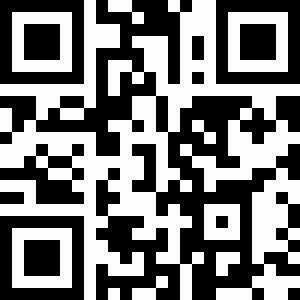



 Space Renaissance France
Space Renaissance France  Space Renaissance USA, Inc.
Space Renaissance USA, Inc.  Space Renaissance Academy
Space Renaissance Academy Space Renaissance Initiative Group
Space Renaissance Initiative Group