Giacomo Cao, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali all’Università di Cagliari, è anche il Presidente del Distretto Aerospaziale della Sardegna. Da anni svolge un’attività incessante di sostegno allo sviluppo civile dello spazio, mediante la ricerca, e senza risparmiarsi nel compito — un obbligo morale per qualsiasi ricercatore — della divulgazione. Sarà uno dei protagonisti, keynote speaker, del Secondo Congresso Nazionale di Space Renaissance Italia, il 18 e 19 maggio 2018, all’INAF di Bologna. Adriano Autino lo ha intervistato.
- “Nuove tecnologie per l’esplorazione robotica e umana di Luna, Marte e Asteroidi, incluse le implicazioni biologiche e mediche e le sperimentazioni su volo parabolico e stazione spaziale orbitante”
- “Sviluppo di sistemi per la sorveglianza, il tracciamento e la predizione delle rotte di oggetti orbitanti intorno alla Terra (detriti spaziali, microasteroidi, ecc.), con lo scopo di aumentare la sicurezza del patrimonio orbitante; supporto alla nascita di un centro nazionale di Space Surveillance and Tracking (SST) e di Space Situational Awarness (SSA)”
Temi di primario interesse, che saranno discussi tra gli altri al secondo congresso nazionale di Space Renaissance Italia, che si terrà presso l’INAF di Bologna il 18 e 19 Maggio 2018. La possibilità di dare effettivamente inizio ad attività civili industriali in orbita terrestre e in area cislunare dipendono dal successo di diversi fattori: sviluppo di sistemi di trasporto passeggeri civili a basso costo, manovrabilità interorbitale, capacità di estrarre carburanti, ossigeno ed acqua da risorse lunari ed asteroidee, protezione dalle radiazioni cosmiche, gravità artificiale, sperimentazione di ecosistemi artificiali, che permettano la vita umana confortevole e sicura su infrastrutture abitative spaziali. Tutto questo è necessario, se si comincia a pensare in termini di residenza e lavoro nello spazio, e non più solo di missioni di esplorazione di durata relativamente breve.
Autino Sappiamo che il DASS è impegnato in ricerche fondamentali in queste aree. Potresti darci un’idea e magari qualche riferimento per consentire un ulteriore approfondimento, dei progetti più interessanti ?
Cao Innanzitutto desidero ringraziare per l’attenzione che viene data alle attività del nostro distretto che ha appena compiuto i suoi primi quattro anni di vita ed è quindi uno degli ultimi arrivati nel panorama dei distretti aerospaziali italiani. Per quanto riguarda il primo tema, mi piace far osservare che il distretto credo sia l’unica realtà distrettuale italiana che detiene diritti brevettuali su due processi ideati per favorire l’esplorazione dello spazio, e in particolare Luna e Marte, proprio con l’obiettivo di allungare i tempi di missione, ragionando di residenza e lavoro nello spazio, attraverso lo sfruttamento delle risorse disponibili in situ. Nello scorso mese di novembre ad esempio è stato sottomesso, da una cordata composta dal distretto in qualità di capofila, dal CIRA, dall’Università di Cagliari e da tre PMI campane, ALI, FOXBIT e LEADTECH, un progetto a valere sul bando MIUR che ha per obiettivo la definizione di una missione di trasferimento sulla superficie di Marte di un processo adatto alla produzione in situ di manufatti di supporto alle future colonie sul pianeta rosso. Per perseguire tale obiettivo il progetto si propone la massimizzazione dell’utilizzo delle principali tecnologie Europee in ambito spaziale, relativamente ai sistemi di lancio, di propulsione, dei sistemi innovativi di protezione termica per rientro atmosferico. Credo sia utile ricordare che uno dei processi di proprietà del distretto nell’ambito di questa tematica sia stato considerato molto positivamente anche nell’ambito dell’ISECG (International Space Exploration and Coordination Group), in particolare con riferimento alla fase di arricchimento del suolo lunare in ilmenite, che è stata anche riconosciuta, sempre in ambito ISECG, una fase perfettamente sinergica con il processo ormai consolidato per la produzione di ossigeno sulla Luna e meritevole di essere testata anche su lander lunare. Per quanto riguarda il secondo tema, ci auguriamo che il più grande radiotelescopio europeo ubicato in Sardegna a San Basilio e gestito da INAF unitamente alle infrastrutture radar presenti presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ) a Perdasdefogu possano dare un significativo contributo al settore dell’SSA e dell’SST. Occorre a tal riguardo operare con lo spirito del sistema Paese mettendo in secondo piano particolarismi di qualunque tipo. Se è vero come è vero che le infrastrutture che vengono in parte dedicate a queste tematiche si trovano in Sardegna, non credo si possa escludere l’isola dalla localizzazione del relativo centro nazionale.

Autino Pensi che l’Italia possa giocare un ruolo primario nella rapida validazione di tecnologie abilitanti per l’espansione civile, e nella soluzione dei problemi essenziali alla sopravvivenza umana nello spazio? Se sì, quali cambiamenti o miglioramenti vedi necessari nelle politiche di sviluppo nel nostro paese?
Cao Ritengo di si. Credo però che sia necessaria la creazione di una task force nazionale che si occupi di questi argomenti con uno spirito inclusivo di tutte le competenze presenti nel Paese e attraverso la messa a disposizione di risorse appropriate. Ho sollecitato fin dal 2012 a tutti i livelli la creazione di una task force di questo tipo e continuerò a farlo fino a che non si raggiungerà l’obiettivo. Mi auguro che il nuovo anno e il nuovo governo del paese possano portare la nascita di un soggetto italiano con queste caratteristiche che possa interfacciarsi con successo e profitto nel settore della sopravivenza umana nello spazio. Mi pare sia necessario trovare un contesto nel quale le competenze maturate fino ad ora possano diventare sinergiche e si possa mettere in campo una strategia per il futuro. Credo inoltre che sia utile e opportuno incentivare il deposito e il mantenimento di domande di brevetto che contemplino tecnologie abilitanti sviluppate in Italia per la sopravvivenza umana dello spazio in modo da poterle abilmente sfruttare nei contesti internazionali sulla scorta delle esperienze degli altri paesi del G8.
Autino Il successo della ricerca dipende da diversi fattori. Oltre alla creatività dei ricercatori sono fondamentali i finanziamenti, il supporto politico, il consenso dell’opinione pubblica. E sappiamo che la ricerca italiana, da molti anni, non se la passa molto bene. Il flusso dei finanziamenti al vostro istituto negli ultimi anni è stato sufficiente per il conseguimento dei vostro obiettivi? Ha consentito ai ragazzi più promettenti usciti dall’Università di trovare spazio nel DASS?
Cao Il distretto è una realtà consortile senza scopo di lucro che per sua natura non potrà dotarsi di eccessive numerosità di personale. Il distretto nasce come veicolo per far crescere i suoi Soci. In questo contesto, il distretto ha avuto e ha tutt’ora in Sardegna un supporto praticamente da parte di tutto l’arco delle forze politiche che hanno recepito l’aerospazio come volano di sviluppo e hanno quindi messo in campo interessanti livelli di risorse per il finanziamento non solo della ricerca nel settore ma anche degli investimenti industriali. Mi piace evidenziare che lo scorso luglio è stato annunciato un investimento nel Sarrabus di una trentina di milioni di euro, adeguatamente cofinanziato con risorse pubbliche, per lo sviluppo di piattaforme di test per motori a propellente solido e liquido per il vettore Vega e per la realizzazione dell’impianto di produzione del materiale composito “carbon-carbon”, utile alla realizzazione dello stesso vettore, con conseguente assunzione di una quarantina di addetti. Naturalmente per poter attrarre grandi player anche stranieri occorre mettere in campo livelli di risorse più significativi.
Autino Ti sembra che l’interessa della politica per il settore spaziale, ed in particolare new space, stia finalmente crescendo, nel nostro paese? Oppure siamo sempre al livello dei visionari che gridano nel deserto?
Cao Mi pare che la percezione stia cambiando in positivo. Occorre far capire alla politica che il Paese dispone ad esempio in Sardegna di infrastrutture quali gli aeroporti di Fenosu, Tortolì e Decimomannu che, unitamente a quelle dislocate presso il PISQ, possono consentire di disporre di un invidiabile “Test range” italiano per il test e la certificazione di velivoli senza pilota che può competere a livello europeo e mondiale. Occorre che la politica si rafforzi nella convinzione che l’aeroporto di Decimomannu può diventare l’infrastruttura di riferimento quale spazioporto italiano per i voli suborbitali. Anche questo è aerospazio, peraltro non disgiunto dalle tematiche dell’esplorazione propriamente detta nella quale la politica non può non rendersi conto che il Paese ha in casa una importante azienda, Avio SpA, che può decisamente competere con la Space X di Elon Musk, con tutto ciò che queste considerazioni comportano.
Autino Ultima Autino, ma non meno importante. Il DASS è certamente uno dei centri di ricerca spaziale più utili ed importanti, nel nostro paese. Cosa pensi dell’informazione mediatica, per quanto riguarda la ricerca spaziale? Ricevete l’attenzione meritata, oppure vi sentite pressochè abbandonati?
Cao L’aerospazio è un settore che si presta molto bene all’informazione mediatica. Dobbiamo cercare di trovare adeguate sponde politiche che si stanno rendendo conto di quanto sia rilevante il settore per il futuro del Paese rispetto a quelli tradizionali, pur importantissimi. Se riusciremo ad avere un ampio sostegno a livello nazionale della stragrande maggioranze delle forze politiche, come è accaduto nelle regioni dove l’aerospazio è fiorente, l’attenzione dei media aumenterà naturalmente e con essa la percezione di quanto lo sviluppo tecnologico e quindi le materie scientifiche siano cruciali per lo sviluppo del Paese.
Iscriviti al Secondo Congresso Nazionale di Space Renaissance Italia, 18 e 19 Maggio 2018, INAF di Bologna.
Presenta un tuo abstract di intervento.
Iscrivi la tua azienda o organizzazione come sponsor del congresso.
Vedi qui tutte le possibilità di partnership.







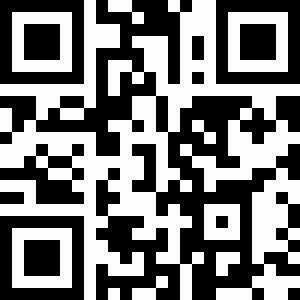



 Space Renaissance France
Space Renaissance France  Space Renaissance USA, Inc.
Space Renaissance USA, Inc.  Space Renaissance Academy
Space Renaissance Academy Space Renaissance Initiative Group
Space Renaissance Initiative Group